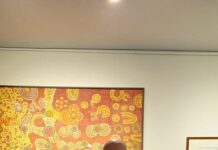di Prof. Ing. Giuseppe Barba
Ingegnere, docente universitario, RSPP, autore del manuale “Elementi di sicurezza sui luoghi di lavoro”, rappresentante di interesse presso la Camera dei Deputati
C’è una legge, in Italia, che chi si occupa di lavoro, cantieri, fabbriche, uffici, scuole non può ignorare: il D.Lgs. 81/2008, noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro. Una norma che, almeno nelle intenzioni originarie, rappresenta una delle più alte espressioni del nostro ordinamento in materia di tutela della salute, della vita e della dignità del lavoratore.
Una legge nata per evitare il peggio, per prevenire infortuni, per ricordare che dietro ogni cartello di cantiere o ogni protocollo c’è una persona.
Eppure, nella mia esperienza quotidiana di ingegnere, docente, tecnico e consulente, mi accorgo ogni giorno di quanto sia ampia la distanza tra la norma e la realtà. Il rischio più grande? Che la sicurezza venga ridotta a una serie di adempimenti burocratici: checklist da firmare, corsi da frequentare “per mettersi a posto”.
Ma la sicurezza è un’altra cosa.
È cultura.
È rispetto.
È consapevolezza.
È un modo di pensare, prima ancora che un insieme di procedure.
Oltre la norma: la sicurezza come percorso umano
Nel mio manuale “Elementi di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro”, frutto di anni di formazione, sopralluoghi, analisi di incidenti e confronti con lavoratori e datori di lavoro, ho cercato di raccontare la sicurezza con un linguaggio accessibile ma rigoroso, tecnico ma umano.
Non solo una raccolta di norme, ma un percorso costruito attorno a domande concrete:
Chi deve fare cosa? Quando? Perché? E soprattutto: cosa accade se non lo fa?
Ricordo ancora un caso emblematico: in un cantiere in cui ero stato nominato coordinatore per la sicurezza, l’impresa aveva copiato da internet il Piano Operativo di Sicurezza (POS). I parapetti erano stati posati solo sul lato esposto alla strada, mentre sul retro – quello che nessuno vedeva – mancavano.
Un operaio cadde.
E a nulla valsero le carte. Perché la sicurezza non si misura in documenti, ma in vite salvate.
Prevenzione attiva: dalla teoria alla prassi
Recentemente ho avuto l’onore di curare il testo guida per un bando INAIL rivolto a sei settori ad alto rischio: agricoltura, edilizia, sanità, trasporti, commercio e turismo. Un lavoro che ha coinvolto docenti, tecnici e professionisti, producendo materiali concreti:
modelli di formazione,
strumenti operativi,
schede pratiche.
Perché la prevenzione non è teoria: è progettazione.
La sicurezza funziona solo se è applicabile, adattabile, accessibile.
Queste linee guida sono state anche al centro del mio intervento al Meeting di Rimini, dove – oltre a rappresentare l’ente promotore – ho voluto portare una visione:
una sicurezza che esca dai convegni e entri nei luoghi reali del lavoro.
Una sicurezza che rimetta al centro l’essere umano, superando l’approccio esclusivamente normativo.
La svolta formativa del 2025
Con l’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni nel 2025, stiamo assistendo a un cambiamento importante nel sistema formativo.
Finalmente anche il datore di lavoro ha l’obbligo di formazione mirata.
Le figure chiave – RSPP, preposti, coordinatori – sono oggi al centro di un percorso più chiaro, con:
contenuti minimi obbligatori,
durate standard,
verifiche dell’apprendimento non solo finali ma anche sul campo.
Personalmente, considero tutto questo un passo avanti necessario.
La formazione vera non si esaurisce in un’aula: si misura nei comportamenti quotidiani.
È ora che venga vissuta non come obbligo, ma come opportunità di crescita, professionale e umana.
Sicurezza invisibile: il pericolo più grande
Nella mia attività – che spazia dai cantieri edili agli ambulatori, dalle scuole ai capannoni – vedo ogni giorno criticità che non si trovano nei manuali:
documenti copiati,
DVR scritti in fretta,
macchinari non verificati,
preposti nominati solo formalmente,
corsi di formazione “flash” via Zoom.
E poi ci sono le persone:
lavoratori che si fidano, ma non sanno;
datori di lavoro che credono di aver fatto tutto con una firma;
colleghi tecnici lasciati soli.
In questo contesto, il vero rischio non è solo l’infortunio.
Il rischio è che la sicurezza diventi invisibile, fino a che non è troppo tardi.
Un nuovo ruolo per una nuova consapevolezza
Da pochi giorni ho assunto l’incarico di Rappresentante di interesse presso la Camera dei Deputati.
Non un punto d’arrivo, ma un nuovo inizio.
Perché credo fermamente che chi ha vissuto la sicurezza dal basso debba oggi portarla in alto:
lì dove si scrivono le norme, si decidono i fondi, si orientano le politiche.
Il mio impegno sarà chiaro:
fare in modo che la sicurezza non sia un obbligo da adempiere, ma un principio fondante.
Un archè, come lo chiamavano i greci:
qualcosa che viene prima, che regge tutto, che dà senso al lavoro, all’economia, alla giustizia.
Conclusione: la sicurezza è civiltà
La sicurezza non fa notizia quando funziona.
Non fa rumore.
Ma è proprio questo il suo potere:
creare normalità protetta, routine sicure, quotidianità rispettosa.
Non è solo tecnica.
È civiltà.
Ecco perché continuerò a fare la mia parte:
come ingegnere, come docente, come autore, come cittadino.
Perché ogni cartello, ogni casco, ogni segnale, ogni piano di sicurezza è molto di più di un obbligo:
è un gesto d’amore verso la vita.